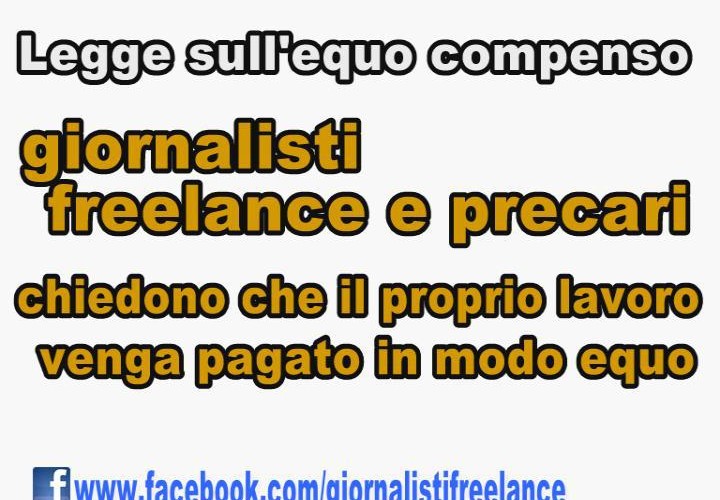Con una veronica degna di una fisarmonica l’altroieri il ministro Fornero ha sbertucciato le decisioni della Camera e affossato il progetto di legge sull’equo compenso per i giornalisti. Allora non ho resistito. E ora spero che Giuseppe Giusti mi perdoni.
Vostra Eccellenza, che mi sta in cagnesco
Per quei quattro postucci di dozzina
E mi gabella per antiministro
Perché metto le birbe alla berlina,
o senta il caso avvenuto di fresco
a me che girellando una mattina
càpito coi senatori del senato,
in quello vecchio, là, ben lobbizzato.
M’eran compagni, non più giovinetti
qualcun dei colleghi un po’ pericolosi,
di quel tal Enzo, capo d’un ordinetto,
che tratta spesso co’ editori esosi.
Che fa il nesci, Eccellenza? O non l’ha visto?
Sì, l’equo compenso. Ma capisco:
in tutt’altre faccende affaccendato,
a questa roba è morto e sotterrato.
Entro, e ti trovo un pien di giornalisti,
di que’ scrittori un poco scoglionati,
come sarebbe autonomi ed ivati,
messi qui nella vigna a far da pali:
difatto se ne stavano impalati,
come sogliono in faccia a’ direttori,
colla testa china e con que’ musi,
pria l’editor, diritti come fusi.
Mi tenni indietro, ché, piovuto in mezzo
di quella maramaglia, io non lo nego
d’aver provato un senso di ribrezzo,
che lei non prova in grazia dell’impiego.
Sentiva un’afa, un alito di lezzo;
scusi, Eccellenza, mi parean di sego,
in quella bella casa della lobby,
fin le poltrone, né mi sembravan troppi!
Ma in quella che s’appresta il presidente
a celebrare l’interrogazione,
di sùbita amarezza mi percuote
su, di verso lo scranno, un suon di banda.
Dalla bocca sua uscian le note
come di voce che prende la distanza,
d’una gente che gema in duri stenti
e de’ perduti beni si rammenti.
Era coro di chi è al verde, il coro a lei
de’ giornalisti miseri, assetati;
quello: “O ministro, dal tetto natio”,
che tante spemi ha scosse ed inebriate.
Qui cominciai a non esser più io
e come se i colleghi doventati
fossero voce della voce mia,
entrai nel branco involontariamente.
Che vuol ella, Eccellenza, il sogno è bello,
poi nostro, e poi creduto come va;
e col soldo di mezzo, e col lavoro
andato in bianco, l’ubbie si buttan là.
Ma sentito il parer suo, bel bello,
io ritornava a star come la sa;
coi dubbi suoi, per farmi un altro tiro,
e quella bocca e la sua presa in giro,
un cantico frignante, lento lento
per il salone a noi rizzò le penne;
era dileggio e mi suonò tormento,
d’un verbo grave, incredibile, solenne,
tal, che sempre nell’anima lo sento:
e mi stupisco che in quelle cotenne,
in noi fantocci esotici di legno,
potesse fia furor fino a quel segno.
Sentia, nell’atto, la dolcezza amara
delle burle subite da fanciullo; il core
che da voce domestica gl’impara,
ce li ripete i giorni del dolore:
un pensier mesto del lavoro caro,
un desiderio di mercede equa,
uno sgomento di lontano esilio,
che mi portava prossimo al deliquio.
E, quando tacque, mi lasciò pensoso
di pensieri più forti e più incazzati.
Costei – dicea tra me – è già paurosa
degl’italici editori e dei lor servi,
strappa a noi il tetto, e qua, senza riposo
schiavi ci spinge, per tenerci schiavi;
spinger si fa, dalle montiane strenne,
a maramaldeggiar su nostre penne.
A dura vita, a dura povertà,
muti, derisi, solitari stiamo,
strumenti ciechi d’occhiuta rapina,
che lor non tocca ma che bene sanno;
e quest’odio, che mai non avvicina
il popolo scrivente all’editore,
giova a chi regna dividendo, e teme
noi giornalisti affratellati insieme.
Povera gente! Poveracci noi;
con un ministro, qui, che ci vuol male,
chi sa, che in fondo all’anima po’ poi,
non si mandi a quel paese il principale!
Tanto l’avranno in tasca come noi.
Qui, se non fuggo, abbraccio un redattore,
col suo bravo contratto e stipendiolo,
duro e piantato lì come un piolo.