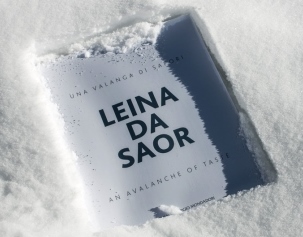Appena uscito, raccoglie storie, ricette, tradizioni, prodotti e aneddoti sul “mangiare” di Livigno, il paese alpino così alto e freddo che può crescerci solo la rapa. E la cui cucina originaria è sopravvissuta finora solo nelle case dei montanari, tra montanari.
Se dicessi che in questo librone c’è del mio, direi una bugia. Eppure un po’ mio lo sento, perchè fin da tempi non sospetti ne ho incoraggiato la realizzazione. Anche quando l’operazione pareva, per costi e dimensioni, improbabile.
E invece eccolo qui. Bello, grosso, candido e denso come nemmeno io avrei mai immaginato: si intitola “Leina da saor“, cioè “Una valanga di sapori” (Editoriale Giorgio Mondadori, 2014, 250 foto, 435 pagine, 50 euro). Complimenti all’Associazione cuochi e pasticceri di Livigno, e al loro testardo presidente Michele Bormolini, per avercela fatta a realizzare quest’opera monumentale.
Spiegare fino in fondo che cos’è significherebbe però raccontare una lunga storia. Quindi, intanto e per sgombrare il campo dagli equivoci, si fa prima a dire cosa, questo libro, non è.
Non è (solo) un libro di cucina, anche se parla di gastronomia. Non è (solo) un libro di ricette, anche se ne contiene 137. Non è (solo) un libro fotografico, anche se il formato è quello e le immagini sono di pregio. Non è (solo) un tomo da tavolino, insomma di quelli decorativi da tenere in vista e basta. Non è un saggio storico, non è un souvenir, non è un catalogo.
E’ invece anche tutte queste cose insieme e soprattutto è un documento, una raccolta, un digesto della memoria gastronomica di una comunità di montagna. Quella di Livigno appunto, alta Valtellina, 1816 metri d’altitudine.
Detto così, sembra banale.
Ma se si pensa che in questa valle, l’unica in Italia (credo) a far parte del bacino idrografico del Danubio (attraverso il suo torrente Spol, che confluisce nell’Inn), si toccano d’inverno i -35°, fa così freddo che l’unica verdura coltivabile è la rapa e che, fino agli anni ’50, per la neve il paese restava praticamente isolato sei mesi l’anno, al punto che i morti venivano lasciati congelati in altura e sepolti al disgelo, forse si capirà come mai si tratta di un posto particolare.
Un posto in cui la società montanara – fatta di tradizioni antiche, di stili di vita spartani e di un’etica tutta sua – è sopravvissuta fino alla generazione corrente e dove, sotto la crosta di modernità dell’odierna località turistica, le vecchie generazioni che l’hanno vissuta e tramandata sono ancora in vita. Uniche custodi di una gastronomia di cui sulle tavole dei ristoranti livignaschi praticamente non c’è, nè mai finora c’è stata, traccia. Ma che, almeno finchè ci sono gli anziani, vive quotidianamente nelle cucine di famiglia. Pressochè invariata.
Il risultato è che a Livigno il verbo “mangiare” segue due coniugazioni, cammina da almeno mezzo secolo lungo due linee parallele: quella standard, del pizzocchero e della taragna, sopra, e quella degli sc’frigol, dei borzat, della lughenia da pàsola sotto.
Piatti strani, arcaici, a volte primordiali, basati su una povertà estrema di ingredienti e sulla valorizzazione del pochissimo messo a disposizione dalla terra e dal bestiame. Latte e suoi derivati, ovunque. Erbe. Farina gialla.
Specialità che fino a ieri erano destinate a sparire piano piano, con la scomparsa degli ultimi che ancora ne conoscono non solo la ricetta, ma la storia e la memoria, per averla vissuta direttamente al desco quotidiano.
E così tre anni fa parte, un po’ in sordina, il censimento dell’esistente, con Michele & friends impegnati a interrogare vecchietti, blandire nonne e zie, sobillare vecchie casalinghe. Sul cibo di una volta e su tutto quello che ci stava intorno: attrezzi, strumenti, occasioni, circostanze, modi, abitudini, usi. E poi la fase delle prove, degli esperimenti, delle rielaborazioni.
In breve, oltre a un prezioso ricettario, ne era venuto fuori un ponderoso documento. Una ricerca vera e propria. Una mole enorme di notizie, sociali e etnografiche più che gastronomiche.
“E ora che ne facciamo?“, si sono chiesti gli chef livignaschi.
“Ne facciamo un libro“, la risposta.
Facile a dirsi. A farsi, parecchio meno. Volontariato a tonnellate, nottate a discutere e a sperimentare. Sponsor che non ci sono. Promesse mancate. Speranze alternate a delusioni. Sessioni fotografiche in una stalla adattata a set, con la tormenta che fischia fuori e i valligiani a fare da modelli, da trovarobe (svuotate cantine e fienili per scovare vecchie suppellettili quasi dimenticate), da consulenti.
Incredibile, ce l’hanno fatta davvero.
Un malloppo che per qualità e dimensioni dovrebbe costare almeno il triplo dei 50 euro che costa. E che si trova in vendita a Livigno e nelle principali librerie italiane.
Gli auguro di avere il successo che merita, perchè è come una solida zeppa, un punto fermo messo a bloccare la slavina della memoria che stava per portarsi via tutto, sapori compresi. La leina da saor, appunto.