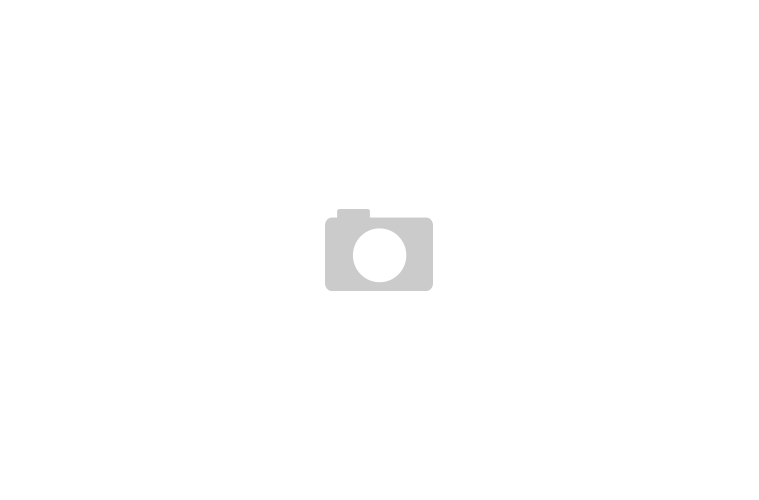Assisto (da tempo, in verità, ma con immutato orrore) all’affermazione nel lessico corrente di espressioni non solo, appunto, orripilanti, ma prive di senso.
Una delle più insopportabili è “fine dining”. Che vorrebbe dire?
Che, siccome ci sono le belle arti (fine arts), ci sono anche le belle cene? Perchè, esistono le brutte cene? Sfamarsi a pasta e fagioli, se fatta bene, non è bello come ingozzarsi di qualche intuglio molecolare di chef vaniloquenti e vanicucinanti? E mangiare male in un locale altolocato non è peggio che mangiare male in una modesta tavola calda? Quindi, cosa è più “fine”, una buona amatriciana in trattoria o un arzigogolo indecifrabile in un autodefinito ristorante “fine”? Che c’è di “raffinato” (traduzione ricorrente di “fine”) nell’uso ghiozzo di una parola straniera?
No, perchè qui si è oltre l’anglobecero.
Cosa impedisce di dire “grande ristorante”, o “ristorante di qualità” al posto di “fine dining”?
Già c’è gourmet, che comunque è termine acquisito e rende l’idea.
A questo punto, mi aspetto l’insorgere della categoria del “fine drinking” con susseguente sequela di sbrodolamenti e puntualizzazioni.
Nell’attesa, propongo di restituire alla parola inglese “fine” il suo significato più pedestre e pregnante: multa. Da elevare a chi della parola stessa fa uso in abbinamento a dining e drinking.