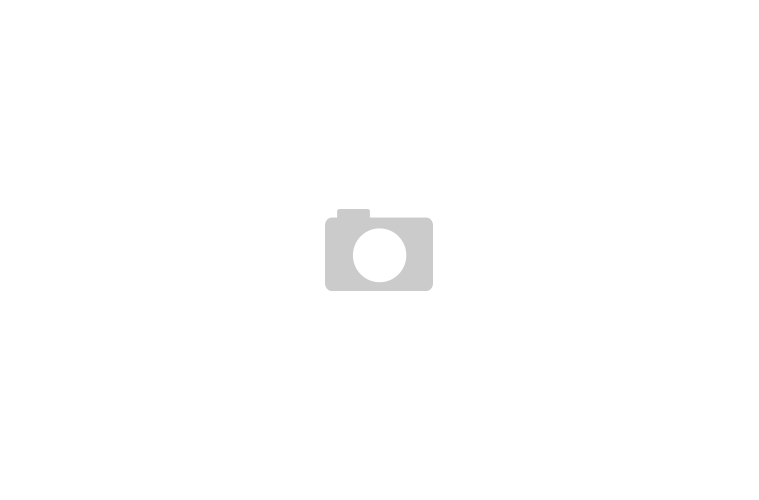Rientro a casa dopo una giornata dagli aromi, diciamo così, assai maleodoranti.
Fuori è quasi buio e tira vento. Dentro c’è un silenzio profondo e irreale.
Entro in cucina e mi guardo intorno: è deserta. Tutto è immobile, quasi plumbeo. Direi cristallizzato, se l’espressione non ricordasse troppo spigoli e linee nette così incompatibli con questa vecchia dimora, storta sotto il peso dei secoli e di antichi intonaci.
Per un attimo avverto il pungolo di nuove, interminabili emergenze da affrontare, di scadenze ansiogene capaci, nel loro virtuale fragore, di incrinare perfino il sibilo sordo di questa abissale quiete domestica.
Poi lo sguardo si posa sul tavolo. C’è un bel pane fresco, croccante, cotto in forno. Al centro troneggia una bottiglia di rosso di quelli semplici, asprigni, di campagna.
L’orologio segna le 18.30.
Rapida escursione in dispensa, dove da tempo è appeso un salamino che ora, d’improvviso, pare essere lì da sempre solo per me.
Lo prendo, lo metto su un tagliere, prendo la vecchia coltella.
Mi siedo. Sì, mi siedo.
Zac, zac, zac, tante belle fette. Crock, crock, crock, la spessa crosta del pane cede sotto la lama seghettata.
Mi riempio un bicchiere di vino.
Realizzo di aver lasciato il telefono in macchina.
Anzichè smadonnare, me ne compiaccio.
Faccio una lunga, silente merenda.
Fuori il vento fischia, dentro nemmeno la polvere s’increspa.
Faccio merenda. Seduto. Da solo. Con pane e salame.
Mai tempo fu speso meglio.