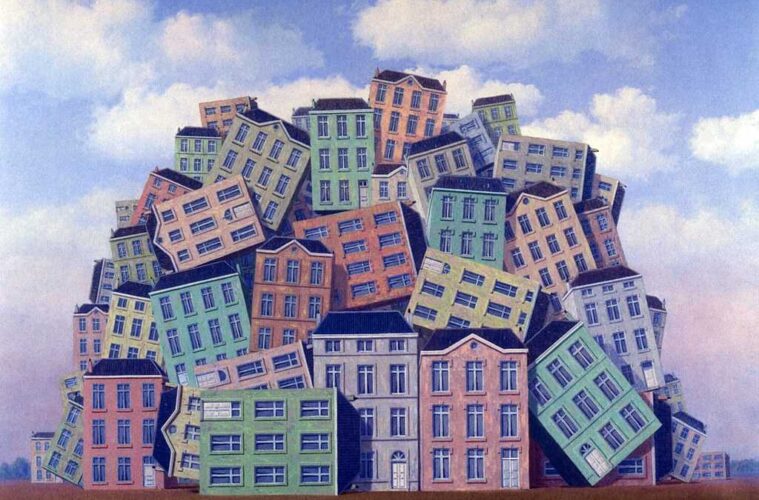Paradosso: ammaestrato dal modello pubblicitario dominante dei social, a volte perfino chi è ben recensito si risente se la recensione non è la perfetta reclame che pretendeva e riteneva dovuta.
Giorni fa ho pubblicato un articolo.
Pacato, equilibrato, veridico ed anche sobriamente positivo nei contenuti, direi.
Dopodichè mi chiama, piuttosto seccato nonostante simulasse il contrario, uno dei tizi menzionati nell’articolo medesimo, lamentandosi che “avresti dovuto scrivere anche che“, “avresti anche potuto sottolineare che“, “non hai fatto presente che“. Il tutto solo perchè le presunte omissioni non risultavano pro domo sua. In pratica avrebbe voluto dettarmi lui cosa scrivere.
Segue mia replica piuttosto irritata e chiusura fintamente amichevole della telefonata.
Succede insomma che tu fai il tuo mestiere di giornalista, quello per il quale hai superato un esame di abilitazione, oltre a quello quotidiano dei lettori, per il quale sei pagato da un editore e non da un terzo interessato, quindi scrivi articoli e recensioni in assoluta autonomia. Eppure, ormai nemmeno più a sorpresa e neanche di rado, succede che pure i ben recensiti si incazzino.
Sottolineo “ben recensiti”: tutto succede, cioè, mica perchè hai scritto male di qualcosa che loro hanno fatto o prodotto (il che peraltro rientra pienamente nel mio ruolo e dovere di cronista). Ma perchè volevano che tu scrivessi solo bene, o ancora meglio, o solo di qualcosa, o mettessi in luce solo ciò che ad essi fa comodo e pure nel modo o nella forma che a loro torna più utile. Naturalmente, va da sè, quelli invece recensiti così così o in negativo, ritenendo che la recensione positiva sia comunque implicita o dovuta, mettono direttamente il muso e minacciano querele.
Insomma ne esci sì sempre professionalmente sereno, ma spesso becco, bastonato e un po’ frastornato. Nonchè piuttosto maldisposto per la totale mancanza di rispetto da parte di chi, in fondo, è stato beneficiato senza sforzi nè spese da un’attenzione mediatica ritenuta, con totale imparzialità da parte di chi scrive e solo di chi scrive, meritevole.
Mi direte: fa parte del gioco. Io però non vedo quale sia il gioco. Chi viene criticato, è naturale che si possa rimanerci male o risentirsi. E anche questo dovrebbe far parte del gioco. Ma gli altri?
E non finisce qui. Accanto a costoro sta fiorendo infatti una fauna sempre più variegata, diciamo di seconda generazione, di equivocanti.
E’ la pletora di amici, amici degli amici, conoscenti, parenti vicini e lontani, gente incontrata per caso in treno, o che non vedi da quarant’anni, o con cui non hai in alcun caso rapporti se non superficialissimi, che la “recensione” te la prospettano, la agognano, la chiedono o addirittura la pretendono. Ovviamente solo una minima parte di loro è in palese malafede: la stragrande maggioranza è convinta invece che una menzione giornalistica sia un’innocente, gratuita “pubblicità” (la chiamano proprio così: se positiva, si capisce) e che essa si generi automaticamente, per conoscenza, per contatto, per osmosi tra te e le loro esigenze o aspirazioni. Quindi se la menzione o il trafiletto entusiastico, a cui pensano di avere diritto per nascita, non “escono”, e alla svelta, ovviamente nei tempi giusti e in termini funzionali ai loro tornaconti, si alterano.
Ho provato miliardi di volte a spiegare loro che non funziona così, ma è inutile.
Gli ho detto che innanzitutto il mio mestiere non prevede articoli compiacenti, anzi proprio li proibisce (please, nessuno tiri fuori la tiritera che “lo fanno tutti, si sa come va, basta pagare, etc“: non è vero, o almeno non lo è sempre e nemmeno così spesso e in ogni caso non mi riguarda). E ho aggiunto che c’è a monte una filiera gerarchica e redazionale in cui le scelte vengono soppesate, condivise e delle quali bisogna rendere conto e quindi, anche volendo, non è che uno si alza la mattina e scrive una recensione tanto per fare un piacere a un amico. Ho concluso facendo presente che, oltretutto, la marchetta amichevole è un’arma pericolosa, perchè una volta smascherata (cosa facilissima), o anche solo dubitata, depriva di qualsiasi credibilità il messaggio, chi lo ha scritto e chi ne ha goduto. Insomma può essere un boomerang e generare sputtanature. Ma non mi è parso di convincere nessuno. Tutti restano convinti che l’informazione equivalga alla pubblicità e che la pubblicità, sempre nell’accezione detta sopra, la faccia chi scrive articoli giornalistici. Il resto, pensano, è fuffa.
L’involuzione subita dal concetto di informazione, giornalistica e non, negli ultimi decenni appestati dai social e dall’endemica propaganda che essi si portano dietro, è insomma incredibile. Talmente incredibile che sfugge ai più, ormai ammaestrati dai padroni della rete.
Per chi ha avuto una formazione professionale seria, o almeno coerente con la funzione della professione giornalistica medesima, ossia appunto informare secondo gli allora pacifici concetti di verità, verifica e terzietà, oggi è difficile orientarsi e ancora di più sopportare circostanze che sembrano, o suonano, come provocazioni.
L’esempio lampante è appunto il concetto di “recensione”.
In un mondo normale, la recensione è un testo critico, lungo o breve, attraverso il quale qualcuno, che ha la competenza e meglio ancora l’abilitazione per farlo, esprime un giudizio imparziale su qualcosa, attribuendo ad essa, con parole o punteggi, un valore, supportato da argomentazioni ed elementi idonei a spiegare a chi legge i motivi di quanto espresso.
Si tratta di attribuzioni che, nel rispettivo campo, spettano appunto a chi è chiamato a giudicare (mestiere difficile, ve lo garantisco) l’opera altrui: giornalisti, critici, docenti, etc.
Naturalmente non è detto che il giudicante sia sempre capace di dare giudizi corretti (tutt’altro!), ma poichè questi rientrano nel suo compito istituzionale, egli ne risponde come minimo davanti ai colleghi e alle leggi professionali, oltre che a quella ordinaria.
Ora, per favore, nessuno ora venga a blaterare la pappardella sull’art. 21, la libertà di espressione etc, che qui nessuno contesta. Mi limito a dire che l’espressione può anche comprendere le sciocchezze, altrimenti dette cazzate, ossia le cose a vanvera quasi sempre pronunciate da chi non sa di cosa parla o non è all’altezza di farlo. Siamo insomma in un campo diverso da quello dell’informazione giornalistica.
Il problema è che oggi nessuno si rifà alla nozione corretta di recensione.
Nel dilagante meccanismo populistico-pubblicitario che ormai domina, la recensione è principalmente il giudizio – più o meno sgangherato, sgrammaticato, delirante, vendicativo, adulatorio, reclamizzante – che non un professionista, ma un nescioquid dà su qualcosa attraverso i social: da Fuffadvisor a FB, da TikTok a Instagram. Solo in subordine viene il resto (stampa, radio, tv, etc), che comunque si dà per scontato obbedisca al medesimo meccanismo.
In questa palude, è ovvio, sguazzano ormai da tempo da un lato un certo giornalismo nativo-marchettaro, reso possibile dalla mancanza di controlli, di formazione e di dignità reddituale, dall’altro i cosiddetti influencer i quali, lecitamente e astutamente (e non posso biasimarli), hanno trovato come ottenere facili guadagni facendo a pagamento e in modo organizzato la propaganda conto terzi che i molti comuni beoti fanno invece gratis e a casaccio con i loro post. Esattamente gli stessi post, però, che la controparte beneficiata anela. Così si chiude il cerchio.
Pertanto, alla fine del giro, non solo le formiche nel loro piccolo ma quasi tutti, anche i giornalisti seri rimasti, si incazzano. Ma della cosa non importa a nessuno, forse nemmeno a chi li rappresenta.
Amen.