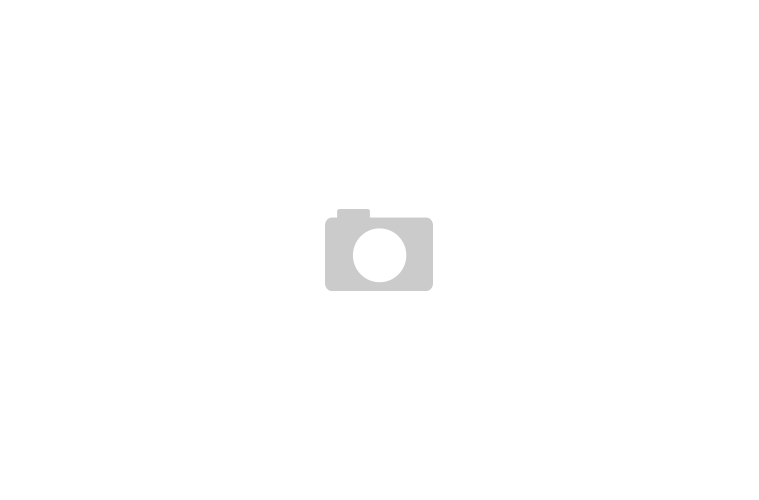Dal combinato disposto, come dicono i giuristi, della lettura di una brutta intervista pubblicata oggi (e un’altra pure ieri) da un famoso quotidiano e del divertente racconto di Riccardo Catola a proposito di una sua intervista a Giorgio Armani di quarant’anni fa ho (ri)maturato la convinzione che la bravura di un giornalista si misura per l’appunto, o almeno in buona parte, dalle sue interviste.
Un genere che, dicono, prima di farle bisognerebbe prepararsi a dovere.
Vero e utile, ma non del tutto.
Perché se poi hai orizzonti limitati, o una conoscenza ristretta del de quo, e le domande non sai farle, o ne sbagli la sequenza, o ti mancano l’intuito, la capacità, l’istinto di insinuarti tra le pieghe di ciò che l’intervistato cerca di non dire, o magari non sa dire, alla fine quello che resta è solo l’evidenza delle tue nozioni appiccicaticce mandate a memoria per l’occasione, con risultati della banalità più prevedibile.
Così prevedibile che l’intervistato ci giocherà al gatto (lui) col topo (tu), invertendo i ruoli e lasciandoti a penna asciutta. Altro che intervista graffiante: i graffi li darà l’interrogato alla tua povera immagine di inquisitore.
I luoghi comuni e l’aneddotica risaputa, del resto, sono il peggiore nemico di chi aspira a porre quesiti intelligenti e, quindi, del giornalista. Essi costituiscono invece l’esca principale per stanare il provincialismo dell’inquirente. Così, della personalità dell’intervistato alla fine si capirà poco o nulla, ma della pochezza dell’intervistatore si capisce tutto e subito.